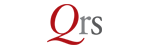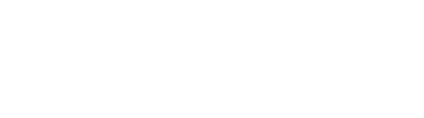- Non puoi aggiungere questa quantità di "Mondo Nuovo e le origini del Psiup" al carrello perché le scorte di magazzino non sono sufficienti (disponibili 0).
-
 L’articolo si concentra sull’introduzione del modello di organizing in Olanda e sulle tensioni relative alla sua implementazione in un contesto di relazioni industriali di tipo neo-corporativo. L’analisi prende in considerazione i fattori che hanno favorito l’emergere delle strategie di organizing, così come i limiti di tale approccio. L’articolo si conclude con alcune riflessioni critiche sul possibile impatto che l’adozione delle strategie di organizing potrebbero avere sul modello di relazioni industriali olandese nel lungo periodo.
L’articolo si concentra sull’introduzione del modello di organizing in Olanda e sulle tensioni relative alla sua implementazione in un contesto di relazioni industriali di tipo neo-corporativo. L’analisi prende in considerazione i fattori che hanno favorito l’emergere delle strategie di organizing, così come i limiti di tale approccio. L’articolo si conclude con alcune riflessioni critiche sul possibile impatto che l’adozione delle strategie di organizing potrebbero avere sul modello di relazioni industriali olandese nel lungo periodo. -
 Da qualche anno l’organizing model sviluppato dai sindacati americani è visto come una promessa di rinnovamento per le organizzazioni sindacali. Tuttavia, fino a poco tempo fa questo modello era considerato appropriato solo per quei contesti in cui i sindacati godono di scarsi sostegni istituzionali e sono fortemente dipendenti dalla propria base associativa per esercitare influenza. L’interesse suscitato da questo modello d’azione fra i sindacati tedeschi è stato, quindi, accolto con sorpresa. Perché le organizzazioni sindacali in Germania, inserite in un sistema istituzionale molto forte e favorevole, stavano guardando alle strategie dei sindacati americani come a un modello da imitare? L’articolo sostiene che la risposta a questa domanda vada cercata nelle trasformazioni che hanno avuto luogo nel sistema di relazioni industriali tedesco e nella consapevolezza maturata dalle organizzazioni sindacali del fatto che, in un contesto sempre più ostile, fosse necessario rafforzare le proprie risorse autonome di potere. Attraverso un’analisi del dibattito e della traduzione pratica del modello organizing in due organizzazioni sindacali tedesche, sosterremo che queste trasformazioni hanno reso sempre più difficile per i sindacati esercitare influenza attraverso i canali tradizionali, spingendo verso un rinnovamento strategico.
Da qualche anno l’organizing model sviluppato dai sindacati americani è visto come una promessa di rinnovamento per le organizzazioni sindacali. Tuttavia, fino a poco tempo fa questo modello era considerato appropriato solo per quei contesti in cui i sindacati godono di scarsi sostegni istituzionali e sono fortemente dipendenti dalla propria base associativa per esercitare influenza. L’interesse suscitato da questo modello d’azione fra i sindacati tedeschi è stato, quindi, accolto con sorpresa. Perché le organizzazioni sindacali in Germania, inserite in un sistema istituzionale molto forte e favorevole, stavano guardando alle strategie dei sindacati americani come a un modello da imitare? L’articolo sostiene che la risposta a questa domanda vada cercata nelle trasformazioni che hanno avuto luogo nel sistema di relazioni industriali tedesco e nella consapevolezza maturata dalle organizzazioni sindacali del fatto che, in un contesto sempre più ostile, fosse necessario rafforzare le proprie risorse autonome di potere. Attraverso un’analisi del dibattito e della traduzione pratica del modello organizing in due organizzazioni sindacali tedesche, sosterremo che queste trasformazioni hanno reso sempre più difficile per i sindacati esercitare influenza attraverso i canali tradizionali, spingendo verso un rinnovamento strategico. -
 Le trasformazioni del mercato hanno determinato in questi anni un crescente allargamento delle distanze tra insider e outsider, tra un nucleo cioè di lavoratori più protetti dal punto di vista della contrattazione e dal sistema di welfare e un crescente e variegato insieme di lavoratori periferici, a bassi salari, con meno tutele contrattuali ed esclusi dai dispositivi ordinari di protezione sociale. In questo quadro il problema della rappresentanza dei soggetti poco o solo parzialmente rappresentati è venuto al centro del dibattito sulle relazioni industriali. In questo articolo si è scelto di focalizzare l’attenzione su quelle forme emergenti di auto-rappresentanza che iniziano a diffondersi per ben delimitate aree del lavoro periferico, spesso a cavallo tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, combinando mix diversi di tutela mutualistica, rappresentanza collettiva e vertenze per il riconoscimento di diritti contrattuali e nuovi diritti sociali. Senza alcuna pretesa di rappresentatività, l’articolo cerca di mettere in evidenza le caratteristiche salienti, le forme organizzative e le metodologie di rappresentanza e tutela adottate da alcune di queste nuove formazioni, che tendono ad aggiungersi e in alcuni casi a interagire con le grandi organizzazioni sociali.
Le trasformazioni del mercato hanno determinato in questi anni un crescente allargamento delle distanze tra insider e outsider, tra un nucleo cioè di lavoratori più protetti dal punto di vista della contrattazione e dal sistema di welfare e un crescente e variegato insieme di lavoratori periferici, a bassi salari, con meno tutele contrattuali ed esclusi dai dispositivi ordinari di protezione sociale. In questo quadro il problema della rappresentanza dei soggetti poco o solo parzialmente rappresentati è venuto al centro del dibattito sulle relazioni industriali. In questo articolo si è scelto di focalizzare l’attenzione su quelle forme emergenti di auto-rappresentanza che iniziano a diffondersi per ben delimitate aree del lavoro periferico, spesso a cavallo tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, combinando mix diversi di tutela mutualistica, rappresentanza collettiva e vertenze per il riconoscimento di diritti contrattuali e nuovi diritti sociali. Senza alcuna pretesa di rappresentatività, l’articolo cerca di mettere in evidenza le caratteristiche salienti, le forme organizzative e le metodologie di rappresentanza e tutela adottate da alcune di queste nuove formazioni, che tendono ad aggiungersi e in alcuni casi a interagire con le grandi organizzazioni sociali. -
 La crisi del conflitto di classe nei paesi occidentali è uno degli eventi politici chiave degli ultimi trent’anni. Nel contempo, la crisi economica contemporanea e i suoi effetti sulla produzione industriale conducono a nuove forme di azione collettiva dei lavoratori, rivolte soprattutto a opporsi alla chiusura delle aziende. L’articolo indaga questo tipo di conflitto di lavoro, i fattori di mobilitazione su cui si basa, la presenza o l’assenza – nelle rappresentazioni dei lavoratori – di riferimenti alla lotta di classe, la vicinanza di queste mobilitazioni al paradigma del sindacalismo tradizionale o a quello del sindacalismo di movimento sociale, la prevalenza al loro interno della radice marxista o polanyiana del conflitto sociale.
La crisi del conflitto di classe nei paesi occidentali è uno degli eventi politici chiave degli ultimi trent’anni. Nel contempo, la crisi economica contemporanea e i suoi effetti sulla produzione industriale conducono a nuove forme di azione collettiva dei lavoratori, rivolte soprattutto a opporsi alla chiusura delle aziende. L’articolo indaga questo tipo di conflitto di lavoro, i fattori di mobilitazione su cui si basa, la presenza o l’assenza – nelle rappresentazioni dei lavoratori – di riferimenti alla lotta di classe, la vicinanza di queste mobilitazioni al paradigma del sindacalismo tradizionale o a quello del sindacalismo di movimento sociale, la prevalenza al loro interno della radice marxista o polanyiana del conflitto sociale. -

-

-

-

-

-

-
 Il saggio è strutturato in varie parti, articolate per singole tematiche. Una prima, divisa in paragrafi, si concentra su alcuni nodi critici dibattuti dalla storiografia più recente: il rapporto tra la Resistenza, la Nazione e lo Stato, la Resistenza civile, il contributo della classe operaia e del sindacato, il tema della violenza e delle stragi sui civili che caratterizzarono il 1943-1945, l’uso pubblico della storia. La seconda parte contiene approfondimenti di tematiche specifiche che riguardano il mondo del lavoro o che sono più vicine alla sua sensibilità: il ruolo della conflittualità operaia, il prezzo pagato all’occupazione tedesca dalla classe operaia, il ruolo delle donne e il tema generazionale della e nella Resistenza.
Il saggio è strutturato in varie parti, articolate per singole tematiche. Una prima, divisa in paragrafi, si concentra su alcuni nodi critici dibattuti dalla storiografia più recente: il rapporto tra la Resistenza, la Nazione e lo Stato, la Resistenza civile, il contributo della classe operaia e del sindacato, il tema della violenza e delle stragi sui civili che caratterizzarono il 1943-1945, l’uso pubblico della storia. La seconda parte contiene approfondimenti di tematiche specifiche che riguardano il mondo del lavoro o che sono più vicine alla sua sensibilità: il ruolo della conflittualità operaia, il prezzo pagato all’occupazione tedesca dalla classe operaia, il ruolo delle donne e il tema generazionale della e nella Resistenza. -