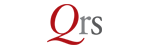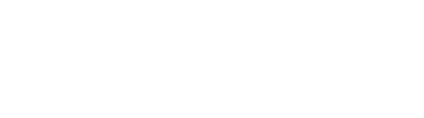- Non puoi aggiungere questa quantità di "Volti e maschere della pena" al carrello perché le scorte di magazzino non sono sufficienti (disponibili 0).
-
 Che ruolo ha l’attore pubblico nelle pratiche di innovazione sociale? Quale è il confine tra integrazione e sostituzione nei rapporti con gli attori auto-organizzati? Quanto e in che misura siamo di fronte a risposte che innalzano la qualità dell’azione pubblica, e a quali condizioni? Per circoscrivere intanto il campo di osservazione intorno a cui è costruita la sezione monografica di questo numero della Rivista delle Politiche Sociali, possiamo dire che qui non siamo interessati ai programmi di riforma su larga scala, ovvero ai cambiamenti in corso o da apportare al fine di contribuire al ridisegno delle policy. L’innovazione sociale rimanda a contesti e dinamiche relazionali più micro che si interfacciano con i processi decisionali e con le pratiche territoriali (Moulaert e al., 2013). C’è tuttavia un nesso con il livello macro che va tematizzato e su cui influiscono diversi fattori, sociali e istituzionali. I contributi raccolti esaminano con prospettive di analisi differenti alcune esperienze di innovazione sociale in Italia e in alcuni paesi europei su diversi ambiti di policy. Senza pretese di esaustività (dato anche l’oggetto di analisi) essi forniscono chiavi di lettura utili a mettere a fuoco il rapporto tra la dimensione dell’innovazione, quella organizzativa, e l’implementazione, spesso trascurata nel policy design. In questa ottica le pratiche esaminate contribuiscono a definire un ambito di ricerca-azione, che può dare spunti per l’analisi delle politiche pubbliche.
Che ruolo ha l’attore pubblico nelle pratiche di innovazione sociale? Quale è il confine tra integrazione e sostituzione nei rapporti con gli attori auto-organizzati? Quanto e in che misura siamo di fronte a risposte che innalzano la qualità dell’azione pubblica, e a quali condizioni? Per circoscrivere intanto il campo di osservazione intorno a cui è costruita la sezione monografica di questo numero della Rivista delle Politiche Sociali, possiamo dire che qui non siamo interessati ai programmi di riforma su larga scala, ovvero ai cambiamenti in corso o da apportare al fine di contribuire al ridisegno delle policy. L’innovazione sociale rimanda a contesti e dinamiche relazionali più micro che si interfacciano con i processi decisionali e con le pratiche territoriali (Moulaert e al., 2013). C’è tuttavia un nesso con il livello macro che va tematizzato e su cui influiscono diversi fattori, sociali e istituzionali. I contributi raccolti esaminano con prospettive di analisi differenti alcune esperienze di innovazione sociale in Italia e in alcuni paesi europei su diversi ambiti di policy. Senza pretese di esaustività (dato anche l’oggetto di analisi) essi forniscono chiavi di lettura utili a mettere a fuoco il rapporto tra la dimensione dell’innovazione, quella organizzativa, e l’implementazione, spesso trascurata nel policy design. In questa ottica le pratiche esaminate contribuiscono a definire un ambito di ricerca-azione, che può dare spunti per l’analisi delle politiche pubbliche. -
 A partire da una ricognizione della letteratura su innovazione sociale e trasformazioni della governance, l’articolo evidenzia il rapporto – a tratti conflittuale – fra dinamiche di innovazione e istituzioni del welfare. La letteratura di riferimento non raramente vede, infatti, queste ultime come un ostacolo a processi di innovazione. Le istituzioni del welfare hanno e possono avere, tuttavia, un ruolo sia di promozione che di supporto ai processi di innovazione sociale, mentre le virtù della società civile vanno situate nel contesto istituzionale in cui agiscono.
A partire da una ricognizione della letteratura su innovazione sociale e trasformazioni della governance, l’articolo evidenzia il rapporto – a tratti conflittuale – fra dinamiche di innovazione e istituzioni del welfare. La letteratura di riferimento non raramente vede, infatti, queste ultime come un ostacolo a processi di innovazione. Le istituzioni del welfare hanno e possono avere, tuttavia, un ruolo sia di promozione che di supporto ai processi di innovazione sociale, mentre le virtù della società civile vanno situate nel contesto istituzionale in cui agiscono. -
 Nel momento in cui il lavoro perde la sua capacità integrativa e il welfare subisce una progressiva riduzione, gli assetti di governance incentivano la capacità di attivazione dei cittadini, ripoliticizzando – almeno in apparenza – ciò che la crisi ideologica e la crescente sfiducia sistemica avevano depoliticizzato. L’articolo analizza due tipologie di innovazione sociale urbana, il cui filo conduttore è rappresentato da un nuovo rapporto tra attori pubblici, privati e terzo settore, intorno a due esigenze primarie: l’abitazione e il lavoro. I casi, rispettivamente, di cohousing e coworking offrono un osservatorio privilegiato per esaminare nuove «socialità istituzionali», ma non si pongono necessariamente in controtendenza rispetto alla città neoliberista, all’interno della quale, piuttosto, rischiano di fornire risorse e visibilità a chi ne ha meno bisogno, vale a dire ai ceti abbienti dotati di un buon capitale culturale.
Nel momento in cui il lavoro perde la sua capacità integrativa e il welfare subisce una progressiva riduzione, gli assetti di governance incentivano la capacità di attivazione dei cittadini, ripoliticizzando – almeno in apparenza – ciò che la crisi ideologica e la crescente sfiducia sistemica avevano depoliticizzato. L’articolo analizza due tipologie di innovazione sociale urbana, il cui filo conduttore è rappresentato da un nuovo rapporto tra attori pubblici, privati e terzo settore, intorno a due esigenze primarie: l’abitazione e il lavoro. I casi, rispettivamente, di cohousing e coworking offrono un osservatorio privilegiato per esaminare nuove «socialità istituzionali», ma non si pongono necessariamente in controtendenza rispetto alla città neoliberista, all’interno della quale, piuttosto, rischiano di fornire risorse e visibilità a chi ne ha meno bisogno, vale a dire ai ceti abbienti dotati di un buon capitale culturale. -
 L’articolo discute il ruolo dei processi trans-contestuali di implementazione e governance nell’innovazione delle politiche sociali e del lavoro in Norvegia e Italia. L’analisi è basata sulla comparazione tra casi-studio qualitativi attraverso il framework teorico-metodologico delle logiche di welfare. Il testo descrive differenze e similitudini tra i due contesti in relazione sia alle caratteristiche dei rispettivi regimi di welfare e dei processi di path dependency, sia ai processi e alle dinamiche bottom-up e top-down e alle varie forme di mobilitazione degli attori. Le riforme hanno avuto un impatto positivo sulle modalità di attuazione delle misure individualizzate nel caso norvegese ed esiti molto più controversi in Italia. In entrambi i paesi modalità e risultati delle riforme appaiono tuttavia localmente differenziati, dipendentemente dai contesti, dalle risorse – non solo economiche – presenti, nonché dai modelli di implementazione, organizzazione e governance. A livello locale, infatti, le logiche in cambiamento possono supportare o ostacolare l’agency e l’attivazione degli attori, con importanti effetti sulla capacità dei sistemi di costruire progetti personalizzati e ridurre i rischi di esclusione sociale e dal mercato. Nel complesso, tuttavia, sia in Norvegia che in Italia le riforme appaiono limitate nella loro capacità di contrastare tali rischi e, con alcune differenze, di incidere sui fattori contestuali di esclusione. In conclusione, da un lato, gli operatori e i policy-maker dovrebbero considerare maggiormente questi ultimi nell’elaborazione e innovazione delle politiche. Dall’altro, una più ampia sperimentazione di analisi comparative attraverso casi-studio in profondità potrebbe migliorare la capacità della ricerca sociale di includere il ruolo dei contesti nell’analisi dei processi di innovazione delle politiche di welfare.
L’articolo discute il ruolo dei processi trans-contestuali di implementazione e governance nell’innovazione delle politiche sociali e del lavoro in Norvegia e Italia. L’analisi è basata sulla comparazione tra casi-studio qualitativi attraverso il framework teorico-metodologico delle logiche di welfare. Il testo descrive differenze e similitudini tra i due contesti in relazione sia alle caratteristiche dei rispettivi regimi di welfare e dei processi di path dependency, sia ai processi e alle dinamiche bottom-up e top-down e alle varie forme di mobilitazione degli attori. Le riforme hanno avuto un impatto positivo sulle modalità di attuazione delle misure individualizzate nel caso norvegese ed esiti molto più controversi in Italia. In entrambi i paesi modalità e risultati delle riforme appaiono tuttavia localmente differenziati, dipendentemente dai contesti, dalle risorse – non solo economiche – presenti, nonché dai modelli di implementazione, organizzazione e governance. A livello locale, infatti, le logiche in cambiamento possono supportare o ostacolare l’agency e l’attivazione degli attori, con importanti effetti sulla capacità dei sistemi di costruire progetti personalizzati e ridurre i rischi di esclusione sociale e dal mercato. Nel complesso, tuttavia, sia in Norvegia che in Italia le riforme appaiono limitate nella loro capacità di contrastare tali rischi e, con alcune differenze, di incidere sui fattori contestuali di esclusione. In conclusione, da un lato, gli operatori e i policy-maker dovrebbero considerare maggiormente questi ultimi nell’elaborazione e innovazione delle politiche. Dall’altro, una più ampia sperimentazione di analisi comparative attraverso casi-studio in profondità potrebbe migliorare la capacità della ricerca sociale di includere il ruolo dei contesti nell’analisi dei processi di innovazione delle politiche di welfare. -
 Il testo mette in rilievo l’importanza delle esperienze di partecipazione dei lavoratori e dell’utenza all’innovazione dell’organizzazione, esperienze non sempre al centro della normativa prevista dai contratti collettivi di lavoro e dalla contrattazione di secondo livello, e come queste due modalità di partecipazione non sempre siano tra loro convergenti: le prime propendono a migliorare le pratiche di adempimento normativo, le seconde la verifica dei risultati del servizio pubblico. Le esperienze qui riportate mettono in ogni caso in evidenza come la partecipazione congiunta lavoratori e utenza, se promossa, garantisca le possibilità di innovazione e più che in altri casi il superamento di una concezione virtuale e amministrativa del cambiamento; disciplini con la definizione dei risultati richiesti la valutazione del personale e in particolare della dirigenza; costituisca un fattore essenziale di trasparenza verso i cittadini; rafforzi le relazioni del personale e contrattuali in ogni singola amministrazione.
Il testo mette in rilievo l’importanza delle esperienze di partecipazione dei lavoratori e dell’utenza all’innovazione dell’organizzazione, esperienze non sempre al centro della normativa prevista dai contratti collettivi di lavoro e dalla contrattazione di secondo livello, e come queste due modalità di partecipazione non sempre siano tra loro convergenti: le prime propendono a migliorare le pratiche di adempimento normativo, le seconde la verifica dei risultati del servizio pubblico. Le esperienze qui riportate mettono in ogni caso in evidenza come la partecipazione congiunta lavoratori e utenza, se promossa, garantisca le possibilità di innovazione e più che in altri casi il superamento di una concezione virtuale e amministrativa del cambiamento; disciplini con la definizione dei risultati richiesti la valutazione del personale e in particolare della dirigenza; costituisca un fattore essenziale di trasparenza verso i cittadini; rafforzi le relazioni del personale e contrattuali in ogni singola amministrazione. -
 In Danimarca, il coinvolgimento degli utenti è un progetto politico di lungo termine, finalizzato a rafforzare la democrazia e ridurre la burocrazia. Inoltre, il sistema di contrattazione collettiva danese ha istituzionalizzato il coinvolgimento dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’articolo indaga il rapporto tra sindacati e organizzazioni di utenti nel settore della scuola dell’obbligo (ossia la Folkeskole, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria inferiore). La riforma del sistema scolastico che, a partire dal 2013, ha introdotto nuove pratiche di gestione dell’orario di lavoro e di valutazione della qualità dell’insegnamento, avrebbe potuto mettere in discussione la relazione tra utenti e lavoratori. Tuttavia, in base alla documentazione disponibile e a una serie di interviste qualitative condotte con le parti sociali attive nel settore, nell’articolo si sostiene che i diversi sistemi riescano a convivere invece di competere tra loro. Ciò è dovuto sia alla maggior forza dei sindacati in confronto alle organizzazioni degli utenti, sia alla capacità costante di politici, dirigenti della pubblica amministrazione, sindacati e insegnanti di comprendere il ruolo importante che le scuole svolgono nel generare e rafforzare la democrazia tramite il coinvolgimento diretto dei cittadini in ogni ambito del sistema scolastico.
In Danimarca, il coinvolgimento degli utenti è un progetto politico di lungo termine, finalizzato a rafforzare la democrazia e ridurre la burocrazia. Inoltre, il sistema di contrattazione collettiva danese ha istituzionalizzato il coinvolgimento dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’articolo indaga il rapporto tra sindacati e organizzazioni di utenti nel settore della scuola dell’obbligo (ossia la Folkeskole, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria inferiore). La riforma del sistema scolastico che, a partire dal 2013, ha introdotto nuove pratiche di gestione dell’orario di lavoro e di valutazione della qualità dell’insegnamento, avrebbe potuto mettere in discussione la relazione tra utenti e lavoratori. Tuttavia, in base alla documentazione disponibile e a una serie di interviste qualitative condotte con le parti sociali attive nel settore, nell’articolo si sostiene che i diversi sistemi riescano a convivere invece di competere tra loro. Ciò è dovuto sia alla maggior forza dei sindacati in confronto alle organizzazioni degli utenti, sia alla capacità costante di politici, dirigenti della pubblica amministrazione, sindacati e insegnanti di comprendere il ruolo importante che le scuole svolgono nel generare e rafforzare la democrazia tramite il coinvolgimento diretto dei cittadini in ogni ambito del sistema scolastico. -
 Fino ad oggi gli studi sull’innovazione sociale si sono concentrati sugli innovatori sociali e, più recentemente, sui ricercatori in azione, presentati come nuovi attori delle politiche sociali. In questo contributo si mette in evidenza che anche le storiche figure del lavoro sociale possono avere un ruolo chiave nel favorire i processi di innovazione sociale. Attraverso tre studi di caso condotti in Veneto – Tre cuori, Alleanze per la famiglia e Piani di intervento in materia di politiche giovanili – l’articolo approfondisce il ruolo agito dai broker dell’innovazione sociale, agenti che rendono fluido lo scambio di informazioni tra gli attori del sistema, facendo lievitare il pluralismo e la governance nei processi di innovazione.
Fino ad oggi gli studi sull’innovazione sociale si sono concentrati sugli innovatori sociali e, più recentemente, sui ricercatori in azione, presentati come nuovi attori delle politiche sociali. In questo contributo si mette in evidenza che anche le storiche figure del lavoro sociale possono avere un ruolo chiave nel favorire i processi di innovazione sociale. Attraverso tre studi di caso condotti in Veneto – Tre cuori, Alleanze per la famiglia e Piani di intervento in materia di politiche giovanili – l’articolo approfondisce il ruolo agito dai broker dell’innovazione sociale, agenti che rendono fluido lo scambio di informazioni tra gli attori del sistema, facendo lievitare il pluralismo e la governance nei processi di innovazione. -
 L’articolo analizza l’evoluzione del sistema di welfare e dei rapporti tra pubblico e privato sociale nella città di Roma, dall’approvazione della legge 328/00 e l’avvio della prima programmazione zonale fino alla crisi, ancora in corso, che ha avuto uno dei suoi momenti più critici a seguito dell’inchiesta giudiziaria culminata negli arresti del dicembre 2014. Da laboratorio di innovazione nei primi anni duemila al sostanziale blocco degli anni più recenti, l’articolo mette in luce le fragilità di un sistema di welfare frammentato e insufficiente, in cui i rapporti con il terzo settore – stampella indispensabile e promiscua all’amministrazione fino all’irrompere delle inchieste – vengono improvvisamente irrigiditi, generando una frattura che peggiora la situazione già precaria dei servizi di welfare. All’interno di un quadro di sostanziale inadeguatezza pubblica, emergono tuttavia nella città esperienze auto-organizzate dal basso, che – tramite la reciprocità ma anche meccanismi di mercato – tentano di fornire risposte sul fronte di vecchi e nuovi bisogni, per mezzo di processi collettivi di ricostruzione sociale.
L’articolo analizza l’evoluzione del sistema di welfare e dei rapporti tra pubblico e privato sociale nella città di Roma, dall’approvazione della legge 328/00 e l’avvio della prima programmazione zonale fino alla crisi, ancora in corso, che ha avuto uno dei suoi momenti più critici a seguito dell’inchiesta giudiziaria culminata negli arresti del dicembre 2014. Da laboratorio di innovazione nei primi anni duemila al sostanziale blocco degli anni più recenti, l’articolo mette in luce le fragilità di un sistema di welfare frammentato e insufficiente, in cui i rapporti con il terzo settore – stampella indispensabile e promiscua all’amministrazione fino all’irrompere delle inchieste – vengono improvvisamente irrigiditi, generando una frattura che peggiora la situazione già precaria dei servizi di welfare. All’interno di un quadro di sostanziale inadeguatezza pubblica, emergono tuttavia nella città esperienze auto-organizzate dal basso, che – tramite la reciprocità ma anche meccanismi di mercato – tentano di fornire risposte sul fronte di vecchi e nuovi bisogni, per mezzo di processi collettivi di ricostruzione sociale. -
 Tra le sfide più spesso evocate per giustificare la necessità di stimolare processi di innovazione sociale (Is) vi sono quelle legate al rapido invecchiamento demografico e ai conseguenti bisogni di assistenza di lungo periodo (Ltc) della popolazione anziana. L’articolo intende proporre una riflessione sui nessi analitico-concettuali e di policy fra Is e misure di Ltc. Dopo aver delineato la portata delle pressioni funzionali esercitate dal processo di invecchiamento demografico sul sistema italiano di protezione sociale, ricostruisce il policy framework sviluppato negli ultimi anni dall’Unione europea. Si considerano sia le linee guida promosse dall’Unione attraverso diversi documenti ufficiali sia i principali progetti di ricerca finanziati dall’Ue sui temi dell’Ltc e dell’innovazione. Concludono alcune riflessioni sul caso italiano, letto in controluce rispetto al policy framework europeo.
Tra le sfide più spesso evocate per giustificare la necessità di stimolare processi di innovazione sociale (Is) vi sono quelle legate al rapido invecchiamento demografico e ai conseguenti bisogni di assistenza di lungo periodo (Ltc) della popolazione anziana. L’articolo intende proporre una riflessione sui nessi analitico-concettuali e di policy fra Is e misure di Ltc. Dopo aver delineato la portata delle pressioni funzionali esercitate dal processo di invecchiamento demografico sul sistema italiano di protezione sociale, ricostruisce il policy framework sviluppato negli ultimi anni dall’Unione europea. Si considerano sia le linee guida promosse dall’Unione attraverso diversi documenti ufficiali sia i principali progetti di ricerca finanziati dall’Ue sui temi dell’Ltc e dell’innovazione. Concludono alcune riflessioni sul caso italiano, letto in controluce rispetto al policy framework europeo. -
 La grande pressione esercitata dalla recente crisi e dalle nuove sfide del XXI secolo richiede un ampliamento e un ammodernamento delle politiche sociali su molti livelli. Le infrastrutture sociali sono fondamentali per il nostro futuro perché plasmano la natura della nostra società e rendono possibili servizi sociali e investimenti in capitale umano. L’articolo evidenzia la necessità di rilanciare le infrastrutture sociali in Europa e come le riforme dei sistemi di protezione sociale europei, in particolare sanità, cura degli anziani e dei minori, istruzione, edilizia sociale, dovrebbero diventare i pilastri per affrontare le grandi trasformazioni che attendono l’Europa di domani. Ciò in virtù del fatto che infrastrutture sociali di alta qualità offrono benefici ai singoli cittadini e alla collettività con ricadute positive sulla società e sull’attività economica aumentando la coesione sociale, l’occupazione e la crescita economica. Infine, vengono fatte alcune proposte innovative su come finanziarle, tra le quali la creazione di un nuovo Fondo europeo per le infrastrutture sociali che si finanzia tramite l’emissione di Euro Social Bond.
La grande pressione esercitata dalla recente crisi e dalle nuove sfide del XXI secolo richiede un ampliamento e un ammodernamento delle politiche sociali su molti livelli. Le infrastrutture sociali sono fondamentali per il nostro futuro perché plasmano la natura della nostra società e rendono possibili servizi sociali e investimenti in capitale umano. L’articolo evidenzia la necessità di rilanciare le infrastrutture sociali in Europa e come le riforme dei sistemi di protezione sociale europei, in particolare sanità, cura degli anziani e dei minori, istruzione, edilizia sociale, dovrebbero diventare i pilastri per affrontare le grandi trasformazioni che attendono l’Europa di domani. Ciò in virtù del fatto che infrastrutture sociali di alta qualità offrono benefici ai singoli cittadini e alla collettività con ricadute positive sulla società e sull’attività economica aumentando la coesione sociale, l’occupazione e la crescita economica. Infine, vengono fatte alcune proposte innovative su come finanziarle, tra le quali la creazione di un nuovo Fondo europeo per le infrastrutture sociali che si finanzia tramite l’emissione di Euro Social Bond. -
 L’articolo sottolinea come, sebbene da riformare, l’Europa rimanga un orizzonte fondamentale perché possa essere riproposto a livello internazionale un governo adeguato dei tormentati processi economici contemporanei e i populismi possano essere contrastati nei loro esiti più regressivi, ma anche perché il neoliberismo possa essere combattuto. Ne discendono implicazioni rilevanti sul ridisegno istituzionale necessario dell’Unione europea e dello stesso euro, nonché la necessità di risalire alle fonti valoriali del processo di unificazione europea, da cui si diparte quella pluralità di idee della stessa Europa che ne staglia un «doppio volto», da un lato quello del mostro tecnocratico, dall’altro quello della visione utopica.
L’articolo sottolinea come, sebbene da riformare, l’Europa rimanga un orizzonte fondamentale perché possa essere riproposto a livello internazionale un governo adeguato dei tormentati processi economici contemporanei e i populismi possano essere contrastati nei loro esiti più regressivi, ma anche perché il neoliberismo possa essere combattuto. Ne discendono implicazioni rilevanti sul ridisegno istituzionale necessario dell’Unione europea e dello stesso euro, nonché la necessità di risalire alle fonti valoriali del processo di unificazione europea, da cui si diparte quella pluralità di idee della stessa Europa che ne staglia un «doppio volto», da un lato quello del mostro tecnocratico, dall’altro quello della visione utopica. -
 Il contributo prende avvio dalla constatazione che cantori dello status quo e sovranisti euroscettici condividono il convincimento che l’accento della costruzione europea sugli aggiustamenti di mercato e su uno «Stato minimo» sia l’unico possibile. In realtà, la teoria delle aree valutarie ottimali mette l’accento su diversi meccanismi di aggiustamento e l’enfasi europea su riforme e austerità non è inevitabile, ma piuttosto il frutto del clima culturale in cui la costruzione europea si è fatta. Una moneta unica in cui Stato e mercato siano entrambi protagonisti nel garantire crescita stabile e convergenza tra i paesi membri sembra non solo possibile, ma anche l’unica via per rilanciare il progetto europeo. L’articolo si conclude con l’analisi di alcune proposte, realiste pur se ancora non maggioritarie nel consesso europeo, che potrebbero andare in questo senso.
Il contributo prende avvio dalla constatazione che cantori dello status quo e sovranisti euroscettici condividono il convincimento che l’accento della costruzione europea sugli aggiustamenti di mercato e su uno «Stato minimo» sia l’unico possibile. In realtà, la teoria delle aree valutarie ottimali mette l’accento su diversi meccanismi di aggiustamento e l’enfasi europea su riforme e austerità non è inevitabile, ma piuttosto il frutto del clima culturale in cui la costruzione europea si è fatta. Una moneta unica in cui Stato e mercato siano entrambi protagonisti nel garantire crescita stabile e convergenza tra i paesi membri sembra non solo possibile, ma anche l’unica via per rilanciare il progetto europeo. L’articolo si conclude con l’analisi di alcune proposte, realiste pur se ancora non maggioritarie nel consesso europeo, che potrebbero andare in questo senso.