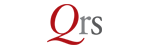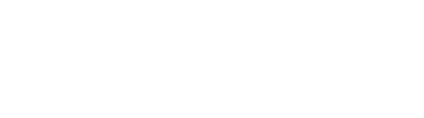- Non puoi aggiungere questa quantità di "Referendum Costituzionale" al carrello perché le scorte di magazzino non sono sufficienti (disponibili ).
-
 Le principali tecnologie di Industria 4.0, strettamente intrecciate con i modelli organizzativi della lean production, determinano conseguenze significative sul lavoro in termini di esternalizzazioni, produttività, tempi e saturazioni, controlli sulle prestazioni lavorative, rapporto uomo-macchina. Il carattere non neutrale della tecnologia comporta l’esigenza di un’analisi critica del suo utilizzo, anche per consentire ai lavoratori di partecipare alla progettazione dei sistemi organizzativi e tecnologici.
Le principali tecnologie di Industria 4.0, strettamente intrecciate con i modelli organizzativi della lean production, determinano conseguenze significative sul lavoro in termini di esternalizzazioni, produttività, tempi e saturazioni, controlli sulle prestazioni lavorative, rapporto uomo-macchina. Il carattere non neutrale della tecnologia comporta l’esigenza di un’analisi critica del suo utilizzo, anche per consentire ai lavoratori di partecipare alla progettazione dei sistemi organizzativi e tecnologici. -
 Il saggio esamina la parabola della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dalla costituzione nel 1972 alla rottura del 1984; tale vicenda storica è collocata all’interno della cornice economica globale, caratterizzata dalla crisi del capitalismo fordista, e all’interno del quadro politico italiano, segnato dalla debolezza delle diverse formule di governo (centro-sinistra, solidarietà nazionale, pentapartito). I principali avvenimenti che si susseguono – dagli accordi generali del 1975 alla linea dell’Eur del 1978, dalla vertenza alla Fiat del 1980 allo scontro sulla scala mobile nel 1984 – mostrano i meriti e i limiti di un progetto sindacale e politico che non ha rappresentato una mera parentesi nella storia nazionale ma un’esperienza significativa, piena di insegnamenti anche per il presente e per il futuro.
Il saggio esamina la parabola della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dalla costituzione nel 1972 alla rottura del 1984; tale vicenda storica è collocata all’interno della cornice economica globale, caratterizzata dalla crisi del capitalismo fordista, e all’interno del quadro politico italiano, segnato dalla debolezza delle diverse formule di governo (centro-sinistra, solidarietà nazionale, pentapartito). I principali avvenimenti che si susseguono – dagli accordi generali del 1975 alla linea dell’Eur del 1978, dalla vertenza alla Fiat del 1980 allo scontro sulla scala mobile nel 1984 – mostrano i meriti e i limiti di un progetto sindacale e politico che non ha rappresentato una mera parentesi nella storia nazionale ma un’esperienza significativa, piena di insegnamenti anche per il presente e per il futuro. -
 Il saggio analizza il ruolo svolto dal sindacalismo non confederale a partire dagli anni sessanta sino alla prima metà degli anni ottanta. In particolare l’autore esamina l’evoluzione storica e le caratteristiche di queste forme di rappresentanza del lavoro nel quadro dei cambiamenti che in questa fase investono il paese da un punto di vista politico, economico e sociale, e che aprono a un maggiore pluralismo in campo sindacale dando vita a forme organizzative e istanze rivendicative che pongono in discussione la legittimità delle tre principali confederazioni, oltre che della stessa Federazione unitaria.
Il saggio analizza il ruolo svolto dal sindacalismo non confederale a partire dagli anni sessanta sino alla prima metà degli anni ottanta. In particolare l’autore esamina l’evoluzione storica e le caratteristiche di queste forme di rappresentanza del lavoro nel quadro dei cambiamenti che in questa fase investono il paese da un punto di vista politico, economico e sociale, e che aprono a un maggiore pluralismo in campo sindacale dando vita a forme organizzative e istanze rivendicative che pongono in discussione la legittimità delle tre principali confederazioni, oltre che della stessa Federazione unitaria. -
 La parte relativa alle interviste di questa ricerca si è rivelata una sorta di rafforzamento di quanto si andava trovando nei documenti. Tuttavia, incontrare alcuni protagonisti di quella formidabile stagione ha reso tangibile quello che era stato il trasporto, il lavorio del confronto e dello scontro, nella necessaria discussione per arrivare a una sintesi politica. Attraverso le interviste la pretesa infatti non era tanto di far venire alla luce particolari novità o informazioni inedite, quanto di rendere viva una stagione: Vanni, Ceremigna, Benvenuto, Roscani, Macaluso, Gabaglio, Carniti, ciascuno con la propria testimonianza è riuscito a raccontare come gli anni della Federazione unitaria siano stati di svolta, di crescita, di progresso della coscienza sindacale, sociale e politica.
La parte relativa alle interviste di questa ricerca si è rivelata una sorta di rafforzamento di quanto si andava trovando nei documenti. Tuttavia, incontrare alcuni protagonisti di quella formidabile stagione ha reso tangibile quello che era stato il trasporto, il lavorio del confronto e dello scontro, nella necessaria discussione per arrivare a una sintesi politica. Attraverso le interviste la pretesa infatti non era tanto di far venire alla luce particolari novità o informazioni inedite, quanto di rendere viva una stagione: Vanni, Ceremigna, Benvenuto, Roscani, Macaluso, Gabaglio, Carniti, ciascuno con la propria testimonianza è riuscito a raccontare come gli anni della Federazione unitaria siano stati di svolta, di crescita, di progresso della coscienza sindacale, sociale e politica. -

-

-
 La digitalizzazione, la diffusione dei computer e dei robot e, ora, l’avvento dell’Intelligenza artificiale e di Internet delle cose stanno determinando importanti cambiamenti nella domanda di lavoro. Molti lavori stanno rapidamente svanendo in quanto automatizzati, e questa sostituzione riguarda non più solo quelli manuali, routinari e a bassa qualifica, ma sempre più attività con una importante componente cognitiva e che richiedono qualifiche medio-alte. In questo articolo esamino brevemente due diverse visioni: una che ritiene che siamo semplicemente in una fase di transizione e che, come nelle precedenti rivoluzioni industriali, alla fine il bilancio tra lavori distrutti e lavori creati sarà positivo sia nel numero sia, soprattutto, nella qualità. L’altra sostiene invece che le caratteristiche economiche delle tecnologie di questa rivoluzione industriale sono profondamente diverse da quelle delle precedenti e che il loro impatto sull’occupazione e sull’uguaglianza sociale rischia di essere complessivamente negativo.
La digitalizzazione, la diffusione dei computer e dei robot e, ora, l’avvento dell’Intelligenza artificiale e di Internet delle cose stanno determinando importanti cambiamenti nella domanda di lavoro. Molti lavori stanno rapidamente svanendo in quanto automatizzati, e questa sostituzione riguarda non più solo quelli manuali, routinari e a bassa qualifica, ma sempre più attività con una importante componente cognitiva e che richiedono qualifiche medio-alte. In questo articolo esamino brevemente due diverse visioni: una che ritiene che siamo semplicemente in una fase di transizione e che, come nelle precedenti rivoluzioni industriali, alla fine il bilancio tra lavori distrutti e lavori creati sarà positivo sia nel numero sia, soprattutto, nella qualità. L’altra sostiene invece che le caratteristiche economiche delle tecnologie di questa rivoluzione industriale sono profondamente diverse da quelle delle precedenti e che il loro impatto sull’occupazione e sull’uguaglianza sociale rischia di essere complessivamente negativo. -
 L’articolo discute l’ipotesi di un reddito di base – un trasferimento monetario individuale, universale e non-condizionato – in un orizzonte temporale di lungo periodo. Nelle sezioni 2 e 3 la proposta è difesa dalle due principali obiezioni che la riguardano: quella di violare il principio di reciprocità e quella di essere economicamente insostenibile. In risposta alla prima, il reddito di base è giustificato come uno strumento che distribuisce in modo equo i frutti di un patrimonio comune, costituito dal capitale sociale che ogni generazione eredita da quelle che l’hanno preceduta; per quanto riguarda la seconda, la risposta verte sulla convinzione che gli effetti di riduzione del tempo di lavoro – attesi e desiderati – non sono comunque tali da pregiudicare la base di prelievo dei trasferimenti. La sezione 4 è dedicata al collegamento della proposta con il tema della disoccupazione tecnologica e con la necessità/ opportunità di affrontarlo nella logica di un’economia plurale, della quale il reddito di base è una condizione di realizzazione.
L’articolo discute l’ipotesi di un reddito di base – un trasferimento monetario individuale, universale e non-condizionato – in un orizzonte temporale di lungo periodo. Nelle sezioni 2 e 3 la proposta è difesa dalle due principali obiezioni che la riguardano: quella di violare il principio di reciprocità e quella di essere economicamente insostenibile. In risposta alla prima, il reddito di base è giustificato come uno strumento che distribuisce in modo equo i frutti di un patrimonio comune, costituito dal capitale sociale che ogni generazione eredita da quelle che l’hanno preceduta; per quanto riguarda la seconda, la risposta verte sulla convinzione che gli effetti di riduzione del tempo di lavoro – attesi e desiderati – non sono comunque tali da pregiudicare la base di prelievo dei trasferimenti. La sezione 4 è dedicata al collegamento della proposta con il tema della disoccupazione tecnologica e con la necessità/ opportunità di affrontarlo nella logica di un’economia plurale, della quale il reddito di base è una condizione di realizzazione. -
 In questo articolo si analizzano i mutamenti nei profili di rischio povertà in alcuni paesi europei, con una particolare attenzione all’Italia e alla Germania, nella stretta connessione tra politiche di contrasto della povertà e i cambiamenti intervenuti nella struttura produttiva. La tesi sostenuta è che il rischio povertà non sia da mettere in relazione solo alla limitatezza o agli orientamenti delle politiche sociali, ma anche alle trasformazioni che hanno investito la struttura produttiva, a partire dal processo di terziarizzazione dell’economia. Troppo spesso il dibattito sul reddito minimo e le varie forme di sostegno del reddito trascura questi aspetti, come se il problema del rischio povertà associato al lavoro potesse essere affrontato solo dal lato delle politiche sociali. Le determinanti della domanda di lavoro rivestono invece una importanza cruciale, anche ai fini di ipotesi di riforma delle politiche di reddito minimo. L’articolo è organizzato come segue. Nella prima parte viene presentato il quadro relativo alle trasformazioni del rischio povertà in Italia e in alcuni paesi europei. Nella seconda il focus è spostato sulla Germania, esaminando i cambiamenti che hanno riguardato le politiche e la struttura del mercato del lavoro. Da qui, nell’ultima parte, il caso tedesco viene confrontato con quello italiano, presentando alcune considerazioni finali sulle politiche di reddito minimo.
In questo articolo si analizzano i mutamenti nei profili di rischio povertà in alcuni paesi europei, con una particolare attenzione all’Italia e alla Germania, nella stretta connessione tra politiche di contrasto della povertà e i cambiamenti intervenuti nella struttura produttiva. La tesi sostenuta è che il rischio povertà non sia da mettere in relazione solo alla limitatezza o agli orientamenti delle politiche sociali, ma anche alle trasformazioni che hanno investito la struttura produttiva, a partire dal processo di terziarizzazione dell’economia. Troppo spesso il dibattito sul reddito minimo e le varie forme di sostegno del reddito trascura questi aspetti, come se il problema del rischio povertà associato al lavoro potesse essere affrontato solo dal lato delle politiche sociali. Le determinanti della domanda di lavoro rivestono invece una importanza cruciale, anche ai fini di ipotesi di riforma delle politiche di reddito minimo. L’articolo è organizzato come segue. Nella prima parte viene presentato il quadro relativo alle trasformazioni del rischio povertà in Italia e in alcuni paesi europei. Nella seconda il focus è spostato sulla Germania, esaminando i cambiamenti che hanno riguardato le politiche e la struttura del mercato del lavoro. Da qui, nell’ultima parte, il caso tedesco viene confrontato con quello italiano, presentando alcune considerazioni finali sulle politiche di reddito minimo. -
 Negli ultimi decenni le politiche di reddito minimo in Europa hanno cambiato poco a poco la loro impostazione originaria. Nate nel secondo dopoguerra come strumenti passivi di protezione del reddito dei poveri, si sono evolute negli anni novanta in politiche di inclusione sociale, capaci di affiancare servizi di inserimento socio-lavorativo al trasferimento monetario, fino a diventare negli ultimi anni vere e proprie politiche di attivazione dei beneficiari. L’articolo prova a chiedersi se la recente influenza dell’approccio del Social Investment nelle politiche sociali europee, sostenuta a livello comunitario, possa aver contribuito a intensificare questa tendenza, oppure se sia il sentiero di policy intrapreso in ogni paese ad aver segnato le singole traiettorie di trasformazione delle politiche di reddito minimo. L’analisi del caso inglese, apripista dell’introduzione del reddito minimo e delle sue trasformazioni in Europa servirà per provare a rispondere a questi interrogativi.
Negli ultimi decenni le politiche di reddito minimo in Europa hanno cambiato poco a poco la loro impostazione originaria. Nate nel secondo dopoguerra come strumenti passivi di protezione del reddito dei poveri, si sono evolute negli anni novanta in politiche di inclusione sociale, capaci di affiancare servizi di inserimento socio-lavorativo al trasferimento monetario, fino a diventare negli ultimi anni vere e proprie politiche di attivazione dei beneficiari. L’articolo prova a chiedersi se la recente influenza dell’approccio del Social Investment nelle politiche sociali europee, sostenuta a livello comunitario, possa aver contribuito a intensificare questa tendenza, oppure se sia il sentiero di policy intrapreso in ogni paese ad aver segnato le singole traiettorie di trasformazione delle politiche di reddito minimo. L’analisi del caso inglese, apripista dell’introduzione del reddito minimo e delle sue trasformazioni in Europa servirà per provare a rispondere a questi interrogativi. -
 Il presente articolo si propone l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dello stato delle politiche di reddito minimo nell’Unione europea. A tal fine vengono analizzati due aspetti principali. Innanzitutto si presentano l’evoluzione storica e i tratti fondamentali degli schemi di reddito minimo nei paesi membri. Inoltre si esamina il ruolo delle politiche di contrasto alla povertà nel dibattito europeo, ritracciando il percorso delle politiche di reddito minimo nelle fonti del diritto europeo (di hard e soft law). Alla luce dei principi idealmente indicati dall’Unione europea dagli anni novanta ad oggi, l’articolo delinea dunque un breve quadro comparativo dello stato dell’arte degli schemi effettivamente vigenti nei paesi membri.
Il presente articolo si propone l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dello stato delle politiche di reddito minimo nell’Unione europea. A tal fine vengono analizzati due aspetti principali. Innanzitutto si presentano l’evoluzione storica e i tratti fondamentali degli schemi di reddito minimo nei paesi membri. Inoltre si esamina il ruolo delle politiche di contrasto alla povertà nel dibattito europeo, ritracciando il percorso delle politiche di reddito minimo nelle fonti del diritto europeo (di hard e soft law). Alla luce dei principi idealmente indicati dall’Unione europea dagli anni novanta ad oggi, l’articolo delinea dunque un breve quadro comparativo dello stato dell’arte degli schemi effettivamente vigenti nei paesi membri. -
 Il contributo affronta il tema del contrasto alla povertà nella prospettiva del diritto del lavoro. Il principio lavoristico che permea la Costituzione osta, di principio, all’erogazione di un reddito a carico della fiscalità generale in assenza di una controprestazione di lavoro. Né tale assunto, ad oggi, è scalfito dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea. L’attuale disciplina del cosiddetto reddito di inclusione, peraltro, non appare idonea a favorire l’inclusione sociale, anche per l’ineffettività degli strumenti di condizionalità. Non sembrano poi sufficientemente valorizzati, nella lotta alla povertà, il ruolo conferito dalla stessa Costituzione alla famiglia e agli enti della società civile.
Il contributo affronta il tema del contrasto alla povertà nella prospettiva del diritto del lavoro. Il principio lavoristico che permea la Costituzione osta, di principio, all’erogazione di un reddito a carico della fiscalità generale in assenza di una controprestazione di lavoro. Né tale assunto, ad oggi, è scalfito dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea. L’attuale disciplina del cosiddetto reddito di inclusione, peraltro, non appare idonea a favorire l’inclusione sociale, anche per l’ineffettività degli strumenti di condizionalità. Non sembrano poi sufficientemente valorizzati, nella lotta alla povertà, il ruolo conferito dalla stessa Costituzione alla famiglia e agli enti della società civile.